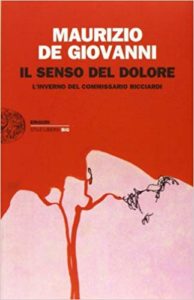
Il bambino morto stava all’impiedi […]. Guardava i due ragazzi che, seduti a terra, facevano il giro d’Italia con le biglie. Li guardava e ripeteva: Scendo? Posso scendere?
L’uomo senza cappello sapeva della presenza del bambino morto ancor prima di vederlo […]. E sapeva pure che al terzo piano del palazzo d’angolo […] un balconcino era serrato; sulla bassa ringhiera restava appeso un drappo nero. Poteva solo immaginare il dolore della giovane madre che, contrariamente a lui, il figlio non l’avrebbe più rivisto. Meglio per lei, pensò. Tutto questo strazio.
L’incipit, così particolare, è quello de Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi, il romanzo che, primo delle celebri Stagioni, ha segnato l’esordio letterario di Maurizio de Giovanni. Un libro particolare, appunto: nato racconto (I vivi e i morti, presentato al concorso per giallisti emergenti indetto da Porsche Italia, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli), è poi stato rivisto, ampliato e pubblicato come romanzo prima per Graus Editore (Le lacrime del Pagliaccio, 2006) poi per Fandango (2007, col titolo odierno, quello definitivo).
E proprio di dolore trattano i fatti immaginati dall’Autore napoletano; dolore, ma pure morte e condanna e arbitrio e costrizione e amore aleggiano sulla trama e i personaggi che la compongono.
Anni ’30. Una notte d’un marzo insolitamente freddo. È la sera della prima di “Pagliacci”, lo spettacolo teatrale di cui il famoso tenore Arnaldo Vezzi avrebbe dovuto essere protagonista indiscusso. Ma Arnaldo Vezzi ha la gola squarciata: è un cadavere dentro un camerino chiuso dall’interno, nelle viscere del San Carlo di Napoli, nei suoi occhi la sfumatura d’una lacrima tardiva.
Ovviamente, la notizia dell’orribile morte scuote l’opinione pubblica; la burocrazia della Città è preoccupata, così come i vertici romani del Partito, di cui il grande tenore era “amico” e strumento di propaganda.
Le indagini toccano a Luigi Alfredo Ricciardi, poliziotto enigmatico e tormentato; è l’uomo “senza cappello” che cammina “a passo svelto”, “le mani infilate nelle tasche del soprabito grigio scuro, la testa incassata nelle spalle” per non dover guardare una Città di cui però sente la Morte; perché Luigi Alfredo Ricciardi percepisce “il dolore”, osserva “il rimpianto, la sofferenza, sente “gli artigli che si spezzano nell’ansia di trattenere l’ultimo lembo della vita che se ne va”: vede, in sintesi, cadaveri, Morte, o meglio, partecipa a “l’ultimo pezzo della vita” che precede la Morte.
Nonostante ciò, o forse proprio per questo, Ricciardi scava più di chiunque altro, in Questura: è un inquirente solerte, implacabile; per questo, nonostante l’invidia e antipatia che suscita in colleghi e superiori, il Caso viene assegnato proprio a lui.
L’indagine lo porterà a scoperchiare il passato nero della vittima, a cercare tra i mille corridoi del teatro San Carlo e poi fuori, nella Napoli degli anni Trenta, una Città iniqua, contraddittoria, insolitamente gelida tra coltri di nubi e brezza sferzante.
E sembra d’esser lì con lui, tanta è la maestria dell’Autore nell’architettare un’ambientazione per certi versi rallentata, dove Tempo e Spazio sostanziano un Mondo quasi zippato, proprio come il suo personaggio principale.
È una realtà, quella di Ricciardi, di uomini e donne perlopiù (ancora) solo abbozzati: il brigadiere Maione, la Tata, il questore e l’assistente, la bella Livia, don Pierino, Maddalena, Michele, la dolce Enrica. Un “popolo” eterogeneo, accattivante, dal quale emerge, unico, il ritratto di Arnaldo Vezzi, “il più grande tenore del suo tempo”, il “preferito del Duce”: un “uomo da poco”, al quale “Dio s’è divertito a dare un talento immenso”; un uomo che “riteneva il mondo intero inferiore a lui e indegno di frapporsi tra lui e il posto che voleva raggiungere”; un uomo che “spazzava via con un gesto della mano, come una mosca, chiunque si trovasse sul suo passaggio”.
Vezzi è dunque un degno anti-antieroe; un pagliaccio in lacrime di fronte alla Fine, vittima “della Fame e dell’Amore”. Attorno a lui si snoda un intreccio in sé non particolarmente complesso, né originale (date anche le sole 189 pagine del manoscritto), ma comunque adatto a presentare Ricciardi e il suo stoicismo tutto particolare: un personaggio (e lo “vedremo” presto anche in TV, nella fiction RAI attualmente in fase di riprese) profondamente innovativo, che ha saputo intrattenere centinaia di migliaia di lettori per più d’un decennio, fino al recente epilogo ne “il Pianto dell’Alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi”, che ha segnato la (degna) conclusione del suo percorso narrativo.
Recensione di Alessio Massaccesi
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.
Compra su Amazon
- Editore: Einaudi
- Autore: Maurizio De Giovanni
Articolo protocollato da Alessio Massaccesi
Libri della serie "Commissario Ricciardi"
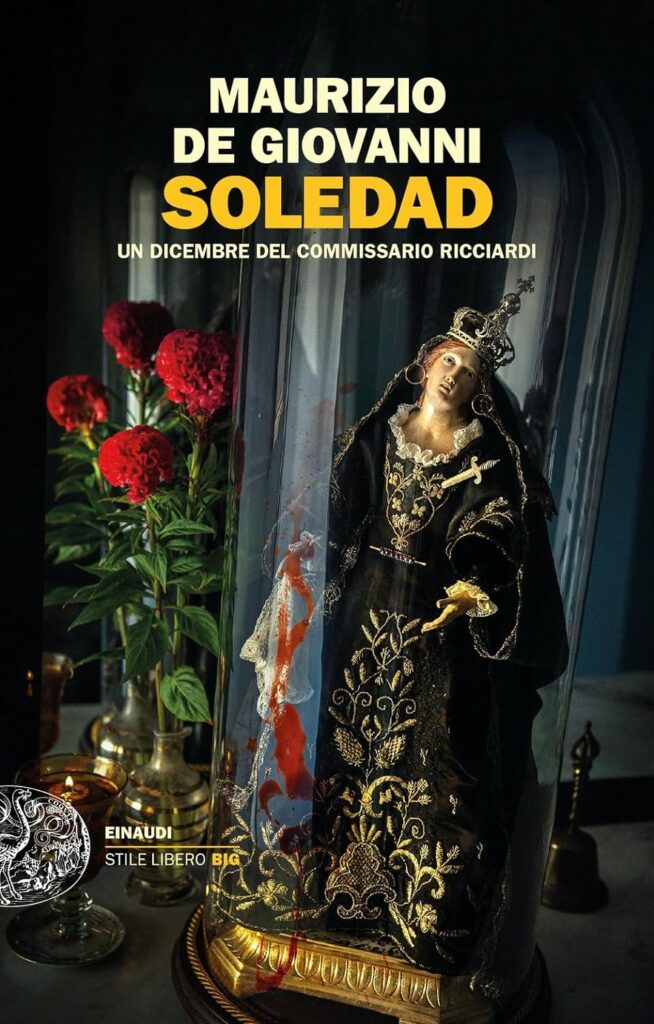
Soledad – Maurizio de Giovanni
Di Soledad, l’ultimo romanzo di Maurizio de Giovanni, si può parlare per il quadro storico che tratteggia con l’ambientazione nel fine anno del 1939, vigilia di guerra. Ma si può parlarne anche come di dettagliato […]
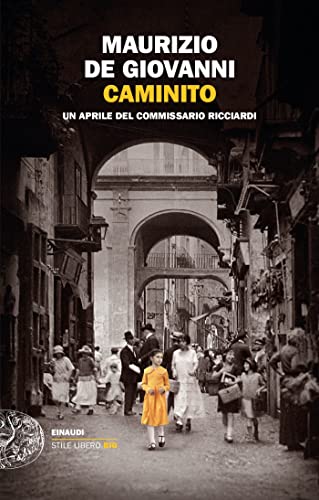
Caminito – Maurizio De Giovanni
Ecco una buona notizia per i nostri avventori del Thriller Cafè: torna il commissario Ricciardi. Nelle scorse settimane è infatti uscito per Einaudi “Caminito” di Maurizio de Giovanni, ultima fatica letteraria del celeberrimo scrittore napoletano. […]
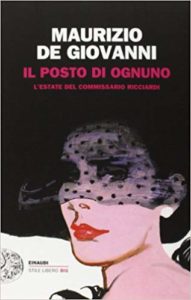
Il posto di ognuno – Maurizio de Giovanni
Un tuono rombò forte, e s’alzò il vento. Ricciardi rabbrividì. La fame, rifletté. E la famiglia Capece […]. E il duca che moriva nel suo letto. E Achille e Ettore e il loro amore senza […]
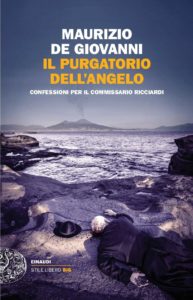
Il purgatorio dell’angelo – Maurizio de Giovanni
Il purgatorio dell’angelo – Confessioni per il Commissario Ricciardi è il libro di Maurizio de Giovanni che recuperiamo oggi al Thriller Cafè. Purtroppo siamo quasi alla fine – questo è il penultimo romanzo della serie ambientata […]
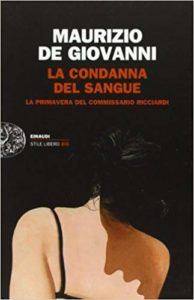
La condanna del sangue – Maurizio de Giovanni
La primavera arrivò a Napoli il 14 aprile 1931, poco dopo le due del mattino. Arrivò in ritardo e, come al solito, con un colpo di vento nuovo dal Sud, dopo un’acquazzone. […] La primavera […]
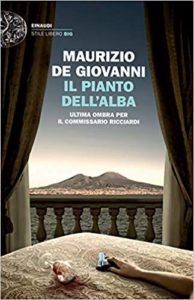
Il pianto dell’alba – Maurizio de Giovanni
Può un uomo che ha sempre dovuto patire, godersi in pace il pezzetto di felicità che alla fine gli è toccato in sorte? No, ovviamente, perché il destino deve metterci del suo e sparigliare le […]
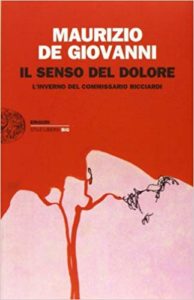
Il senso del dolore – Maurizio de Giovanni
Il bambino morto stava all’impiedi […]. Guardava i due ragazzi che, seduti a terra, facevano il giro d’Italia con le biglie. Li guardava e ripeteva: Scendo? Posso scendere? L’uomo senza cappello sapeva della presenza del bambino […]

L’ultimo passo di tango – Maurizio De Giovanni
Riprendiamo, per tutti i fan di Maurizio De Giovanni, la recente pubblicazione di L’ultimo passo di tango nella collana Vintage di Rizzoli. L’ultimo passo di tango fa tornare in pista il commissario Ricciardi, e dire del noto protagonista creato […]
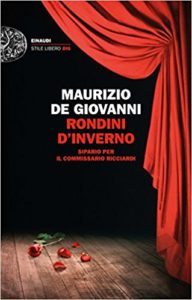
Rondini d’inverno – Maurizio De Giovanni
Piacevoli tappe forzate per Maurizio De Giovanni che ha appena pubblicato Rondini d’inverno, una nuova indagine della serie dedicata alle indagini del commissario Ricciardi. Apparso in libreria con il sottotitolo “Sipario per il commissario Ricciardi”, […]
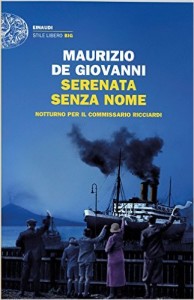
Serenata senza nome – Maurizio De Giovanni
Con Serenata senza nome, che ha per sottotitolo Notturno per il commissario Ricciardi ed è pubblicato come di consueto da Einaudi nella collana Stile Libero Big, Maurizio De Giovanni aggiunge un nuovo tassello alle indagini […]
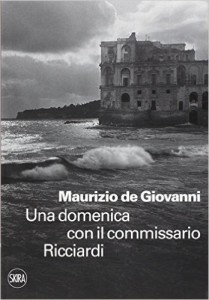
Una domenica con il commissario Ricciardi – Maurizio De Giovanni
Skira ha pubblicato, all’interno della collana StorieSkira, Una domenica con il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni, volume che corona un 2015 che per il bravo autore napoletano è stato anno memorabile, con un’ottima progressione […]
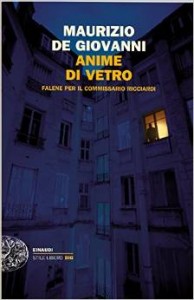
Anime di vetro – Maurizio De Giovanni
Einaudi pubblica, nella collana Stile Libero Big, Anime di vetro, nono romanzo della serie del commissario Ricciardi, a testimonianza dell’incredibile prolificità e bravura di un Maurizio De Giovanni sempre più scatenato e in grado di […]
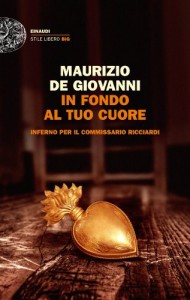
In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi – Maurizio De Giovanni
Attesissimo dai fan di Maurizio De Giovanni esce finalmente In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi, il nuovo romanzo con protagonista il commissario della Squadra Mobile della Questura della Regia Polizia di […]
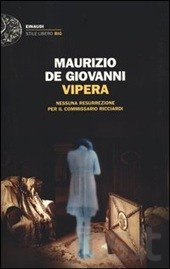
Vipera – Maurizio De Giovanni
In occasione della nomina a finalista della sestina nella 61 edizione del Premio Bancarella 2013, si ritorna a parlare di uno dei commissari più amati dalla letteratura italiana, ovvero Luigi Alfredo Ricciardi protagonista del romanzo […]
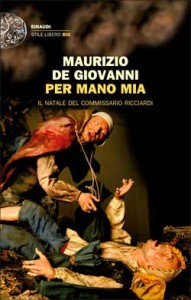
Per mano mia – Maurizio De Giovanni
La segnalazione di oggi al Thriller Café è per un romanzo molto atteso: Per mano mia, nuova opera di Maurizio De Giovanni. Dopo essersi tolto diverse soddisfazioni, tra cui la vittoria ai premi Camaiore, Nebbia […]
