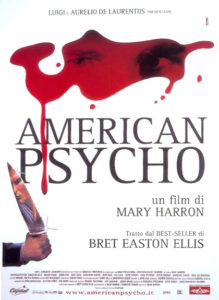Gli occhi della notte (Wait Until Dark), Terence Young, USA 1967
Gli occhi della notte (Wait Until Dark), Terence Young, USA 1967
Sinossi: Un fotografo entra casualmente in possesso di una bambola in cui sono nascoste delle bustine di eroina. Sua moglie Susy, mentre il marito è fuori per lavoro, cieca e sola nell’appartamento, si difende da tre delinquenti che la sequestrano per recuperare la droga.
L’handicap è uno dei più potenti generatori di suspense in circolazione. Da un punto di vista narrativo, infatti, la disabilità non si riferisce mai soltanto a una menomazione che limita le capacità dell’eroe ma è, più originariamente, il segnale di una mancanza che anela insieme a una completezza e a una pacificazione e, nel caso di una non vedente come il personaggio interpretato da Audrey Hepburn, chiama lo spettatore a farsi carico in prima persona del suo sguardo mancante. Saremo noi a vedere per lei.
Partiamo da una considerazione tassonomica. Gli occhi della notte è, a tutti gli effetti, un Kammerspiel, sia a causa del suo svolgersi sostanzialmente in un unico ambiente, sia perché l’impianto narrativo e la messa in scena rimandano in continuazione alla sua originaria forma teatrale, con l’impressione – che si fa via via più concreta – di trovarsi proprio lì, davanti al proscenio, talmente vicini da rischiare quasi di essere visti. Voyeurismo all’ennesima potenza quello rivolto verso una cieca, perché sicuro di non poter essere contraccambiato.
A eccezione del cappello iniziale, che fornisce le informazioni necessarie allo sviluppo del conflitto narrativo principale, tutto il film è dunque ambientato nel piccolo appartamento della protagonista. Nelle prime fasi, come nel tutorial di un videogame, mentre i cattivi fanno il loro ingresso in scena e il focus narrativo sembra incentrarsi su di loro e sul diabolico piano del machiavellico villain Roat (un enorme Alan Arkin), ci impratichiamo progressivamente con il piccolo ambiente domestico: il taglio delle inquadrature, le panoramiche, i movimenti di macchina, le scelte registiche, tutto sembra in qualche modo sottintendere una specie di implicito “memento” rivolto allo spettatore, che suggerisce che la dislocazione di elettrodomestici, finestre, sedie, armadi avrà una certa rilevanza nel corso del film. Non sappiamo ancora in che direzione andrà il plot, non abbiamo ancora incontrato la protagonista, ma abbiamo già intuito che quello spazio, quella mobilia, tutto quello che sta dentro la piccola abitazione rivestirà un ruolo importante nell’economia narrativa. Ѐ lì, in quell’appartamento, percepibile da subito come una mousetrap, che si giocherà la partita.
D’altra parte, quello di Terence Young è un film perfettamente lineare, privo com’è di anacronie temporali e di spazi-tempi altri, talmente diretto e immediato da non avere neppure bisogno di un fuoricampo. Tutto è già perfettamente alla presenza e a portata di mano, compresi la bambola – classico macguffin à la Hitchcock – e il cadavere della ex complice in malaffari di Roat, Lisa, che penzola come un abito nel guardaroba della protagonista. O meglio, se il fuoricampo è ciò che non si vede direttamente, per il personaggio interpretato da Audrey Hepburn tutto si dà solo in fuoricampo.
La menomazione di Susy viene rivelata con un colpo di scena. Prima di conoscere la sua condizione e prima ancora di vederla (solamente attorno al 20’ del film – ritardo ampiamente pre-meditato per aumentare la curiosità/attesa dello spettatore), siamo già venuti a sapere che sarà oggetto di una pericolosa truffa/messinscena che potrebbe costarle la vita. Quando vediamo entrare Susy e veniamo a sapere che è anche cieca, il livello di identificazione/empatia e conseguentemente quello della suspense aumentano all’ennesima potenza. Tanto più, appunto, che lo spettatore, a differenza dell’eroina, è perfettamente a conoscenza di quello che sta per succedere. Il gap informativo è qui ovviamente necessario a innescare la suspense e a precisare la domanda narrativa su cui si reggerà il film: come farà la cieca e indifesa Susy a uscire viva da una lotta così impari?
Il setup/primo atto è quindi tutto finalizzato alla mappatura dell’ambiente in cui si svolge il film. Per la cieca Susy è essenziale che ogni oggetto sia sempre nella stessa posizione, è indispensabile avere un modus vivendi codificato e rigoroso che le permetta di supplire alla sua condizione di cecità. La sua pratica di mondo è in gran parte modellata sul suo appartamento, all’interno del quale la donna si può muovere con sufficiente disinvoltura. Gli oggetti per lei non sono soltanto dei semplici utilizzabili, sia perché in essi Susy proietta delle funzioni emotive vicarie (li tocca e li odora in continuazione), sia perché senza la loro presenza rassicurante e familiare non riuscirebbe a orientarsi: il semplice spostamento di una sedia spezza (o peggio: problematizza) la catena di nessi logico-causali che le consentono di vivere. II problema per Susy non sono tanto le cose che le si parano davanti, bloccandole il passaggio, ma, all’opposto, la mancanza di oggetti, di spazi interstiziali tra le cose. Il terrore della donna scaturisce dagli spazi vuoti che le impediscono di appoggiarsi e sostenersi con ciò che già conosce e padroneggia: un horror vacui che aumenta progressivamente man mano che i tre malviventi prendono possesso dell’appartamento.
L’angoscia della donna (e dello spettatore) esplode quando viene a sapere che anche Mike, il falso alleato su cui aveva investito tutte le sue speranze, fa parte del complotto ordito ai suoi danni per recuperare la bambola. Il percorso di progressivo isolamento dell’eroina in quel momento raggiunge il suo acme emotivo: è proprio quella definitiva e sconsolata agnizione che risveglia Susy dalla sua immedesimazione deiettiva con le cose, provocando in lei un vero e proprio “spaesamento” che fa sì che il (suo) mondo, inteso come totalità di strumenti e significati connessi da rapporti funzionali, riveli improvvisamente la sua inconsistenza e la sua precarietà. Ѐ solo in quel momento, quando tutto sembra ormai inesorabilmente perduto, che Susy riesce ad attingere alle sue energie più riposte e autentiche, elaborando una nuova strategia esistenziale che le consente di combattere alla pari con i suoi nemici, portandoli a giocare sul suo stesso terreno, quello del buio e delle tenebre. Ѐ lì che vincerà la sua battaglia perché la mancanza di un organo aumenta infinitamente la perspicacia e la potenza degli altri sensi (disability superpower).
Anche il personaggio della plucky girl, Gloria, è molto importante per l’economia del dispositivo di suspense messo in atto nel film e questo per due ordini di motivi. La ragazzina è la protesi di Susy, il suo sguardo vicario e il suo angelo custode. Ma Gloria è anche la quintessenza della filobate. I continui richiami all’avventura non la spaventano, ma anzi la galvanizzano e la eccitano, laddove Susy è, all’opposto, il prototipo della persona ocnofila, che ha paura di tutto. Ha paura di essere lasciata sola, ha paura di non essere all’altezza delle aspettative del marito, ha paura di non riuscire a venire a patti con la propria condizione.
Ѐ proprio questa dialettica inesausta tra paura ed eccitazione, tra guardare ed essere guardati, tra pericolo e salvezza, tra personaggi estremi (ma in fin dei conti speculari) in cui il gioco delle polarità morali è caricato fino al parossismo (da una parte il perfido e terrificante – ma alla fine caricaturale Ax Crazy interpretato da Alan Arkin – e dall’altra la povera e indifesa cieca Susy), a costituire la cifra più essenziale del film, che si configura fin dalle prime battute come un perfetto congegno ludico, come un diabolico hide and seek che procede a colpi di thrill.
Del resto sappiamo perfettamente che Audrey Hepburn non può morire, le convenzioni di genere e lo status symbol della diva ci tranquillizzano sin da subito rispetto agli esiti del film. L’happy end è scontato ed è, in fondo, proprio questa consapevolezza sotterranea che ci fa sussultare ed emozionare per quasi due ore, amplificando e sostenendo all’ennesima potenza le dinamiche della suspense.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.
Compra su Amazon
- Hepburn,Arkin,Crenna (Attore)
- Valutazione del Pubblico: G (audience generale)